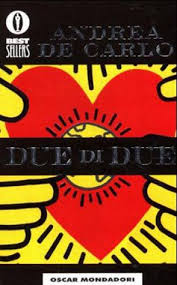

La prima volta che ho visto Guido Laremi eravamo tutti e due così magri e perplessi, così provvisori nelle nostre vite da stare a guardare come spettatori mentre quello che ci succedeva entrava a far parte del passato, schiacciato senza la minima prospettiva. Il ricordo che ho del nostro primo incontro è in realtà una ricostruzione, fatta di dettagli cancellati e aggiunti e modificati per liberare un solo episodio dal tessuto di episodi insignificanti cui apparteneva allora.
In questo ricordo ricostruito io sono in piedi dall’altra parte della strada, a guardare il brulichio di ragazzi e ragazze che sciamano fuori da un vecchio edificio grigio, appena arginati da una transenna di metallo che corre per una decina di metri lungo il marciapiede. Ho le mani in tasca e il bavero del cappotto alzato, e cerco disperatamente di assumere un atteggiamento di non appartenenza alla scena, anche se sono uscito dallo stesso portone e ho fatto lo stesso faticoso percorso solo un quarto d’ora prima. Ma ho quattordici anni e odio i vestiti che ho addosso, odio il mio aspetto in generale, e l’idea di essere qui in questo momento.
(Andrea De Carlo, Due di due, Mondadori, Milano 1989)



